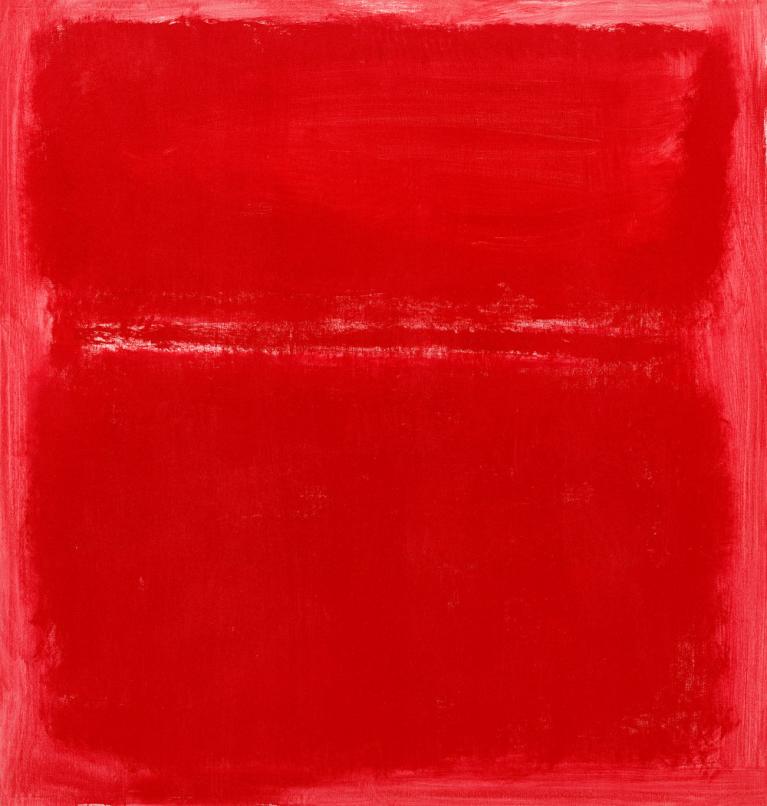Stiamo entrando in una nuova epoca e nessuno sembra rendersene conto. Di tanto in tanto giornali e televisioni riportano qualche notizia; se ne parla per un paio di giorni poi tutto viene macinato dal tritacarne dell’attualità. L’ultima, di qualche settimana fa, riguarda Kepler, una sonda della Nasa che prende il nome dal grande astronomo tedesco. La sua missione è la scoperta di esopianeti, o pianeti extra-solari, che orbitano cioè attorno ad altre stelle; il fine ultimo è quello di identificare pianeti abitabili, simili alla nostra Terra.
Le primissime ricerche risalgono addirittura agli anni Quaranta, ma utilizzavano tecniche di osservazione piuttosto grossolane. Usando i migliori telescopi allora disponibili si cercavano nuovi sistemi solari sperando di osservare una perturbazione periodica nella posizione della stella-madre. È ben noto che, per le leggi della gravitazione, in presenza di un pianeta la stella-madre non sta ferma, ma compie anch’essa una piccola rotazione intorno al centro di massa del sistema. Tanto più massiccio è il pianeta tanto maggiore è lo spostamento periodico della stella. Il metodo, detto astrometrico , non ha portato a risultati di rilievo; sono stati identificati un gruppo di potenziali candidati ma nessuno è mai stato confermato.
Risultati molto più interessanti si sono avuti con il metodo della misura della velocità radiale . Il principio è lo stesso, si cerca di osservare il minuscolo spostamento periodico della stella-madre, ma la tecnica è basata su misure spettroscopiche che consentono maggiori precisioni. Si analizza lo spettro di emissione luminosa della stella e si controllano nel tempo le righe corrispondenti alle varie frequenze. Se la stella presenta un piccolo movimento orbitale causato dalla presenza di un pianeta, si misura una piccola variazione periodica in frequenza della sua emissione luminosa dovuta all’effetto Doppler. Quando la stella ha una velocità radiale positiva — cioè si avvicina al nostro punto di osservazione sulla Terra — le righe di emissione si spostano verso il blu, per poi passare dal lato opposto, verso il rosso, quando la stella si allontana. È lo stesso metodo che ci permette di riconoscere, dal suono della sirena, se un’ambulanza si sta avvicinando o si sta allontanando. Con la misura della velocità radiale della stella possiamo calcolare il periodo del moto orbitale del pianeta e la sua massa.
I primi pianeti extra-solari sono stati scoperti, con questo sistema, negli anni Novanta. Si trattava di enormi corpi celesti, simili al nostro Giove. Giganti caldi, per lo più gassosi, che gravitavano molto vicini alle loro stelle-madri e avevano quindi una temperatura superficiale spaventosa.
Il metodo della velocità radiale è limitato dal fatto che si deve osservare una stella per volta ed è efficace solo per stelle relativamente vicine a noi, si fa per dire, entro una distanza di circa 160 anni luce, mentre la stragrande maggioranza delle stelle della nostra galassia sta a distanze maggiori.
La vera rivoluzione nella caccia ai pianeti extra-solari è venuta da quando è stato messo a punto il metodo dei transiti . È una tecnica basata sulla fotometria di precisione, cioè si tiene sotto controllo la luminosità della stella e si misura la lievissima attenuazione della luce prodotta dal pianeta che le transita davanti. Anche in questo caso si richiede che la perturbazione, il segnale di transito, abbia carattere periodico. La forma caratteristica del disturbo permette di misurare le dimensioni del pianeta e questa informazione, combinata con la misura della velocità radiale che dà la massa, permette di conoscerne la densità.
In questo modo, da alcuni anni, la ricerca di nuove «Terre» ha ricevuto un impulso incredibile e si sono identificati i primi pianeti rocciosi simili al nostro.
Il grande vantaggio del metodo dei transiti è che si possono tenere sotto osservazione, in contemporanea, centinaia di migliaia di stelle e la sensibilità raggiunta dagli strumenti più moderni è tale che il campo d’azione si può estendere fino a distanze di migliaia di anni luce. La sensibilità del metodo è talmente spinta che si possono identificare pianeti addirittura più piccoli di Mercurio. Occorre poi considerare che, nel caso che il pianeta abbia una atmosfera, la luce della stella-madre giunge fino a noi dopo averne attraversato gli strati superiori. Misure accurate della polarizzazione della luce emessa dalla stella permettono quindi di ricavare informazioni essenziali sulla presenza di atmosfera nel pianeta.
L’unico problema del sistema dei transiti è che, per produrre segnali il punto di osservazione deve appartenere al piano delle orbite, cosa che statisticamente avviene solo per una frazione delle stelle osservate. Se poi si cercano pianeti simili alla Terra, che hanno una massa compresa fra metà e due volte quella del nostro pianeta, e che compiono una rivoluzione completa intorno alla loro stella in circa un anno, occorre aspettare molti anni per essere sicuri di avere visto un transito periodico.
Kepler è un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, che sorveglia da anni una piccola zona del cielo compresa fra le costellazioni del Cigno e della Lira. L’apparato tiene sotto controllo circa 150 mila stelle della nostra galassia, distribuite in una regione di dimensioni paragonabili a quella che copriamo con il palmo della nostra mano, se tendiamo il braccio verso il cielo.
La zona di osservazione copre un cono di circa duemila anni luce intorno al nostro Sole che si trova in Orione, un piccolo braccio secondario della spirale che costituisce la nostra Via Lattea. Il telescopio è ottimizzato per misure di fotometria e utilizza un sistema di camere fotografiche molto sofisticate, da 95 milioni di pixel, ma concettualmente simili a quelle che usiamo nei nostri cellulari.
Un mese fa gli scienziati di Kepler hanno annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari. La maggior parte dei nuovi corpi celesti sarebbero posti assolutamente inospitali, caratterizzati da atmosfere molto dense, composte essenzialmente da elio e idrogeno, e temperature torride alla superficie. Ma la novità davvero eclatante è la scoperta che pianeti simili alla Terra sono corpi celesti molto comuni fra quelli che orbitano intorno alle stelle. Fra i nuovi venuti almeno nove dovrebbero essere pianeti rocciosi che si trovano nella fascia cosiddetta abitabile, cioè a una distanza dalla stella-madre tale da consentire temperature simili a quelle che abbiamo qui da noi. Se un pianeta roccioso si trova nella fascia abitabile e contiene acqua, questa potrebbe formare laghi e oceani come quelli che sono così diffusi sulla nostra Terra. Ecco che, di colpo il numero dei nostri potenziali cugini è quasi raddoppiato. E la cosa sorprendente è che Kepler ha osservato soltanto una piccola porzione della nostra galassia. Si stanno già preparando nuove missioni e nuove campagne di osservazioni e nel prossimo futuro si costruirà una mappa sempre più dettagliata delle «nuove Terre». Nel giro di un paio d’anni sarà lanciato un nuovo telescopio per tenere sotto osservazione le 200 mila stelle più vicine a noi fra le quali ci si aspetta di scoprire 500 pianeti rocciosi simili al nostro.
La nostra Via Lattea contiene circa 200 miliardi di stelle ed è soltanto una fra cento miliardi di galassie che popolano il nostro universo. I numeri fanno impressione: se soltanto una stella su diecimila ospitasse pianeti rocciosi nella fascia abitabile dovremmo accettare l’idea che il numero di «Terre» della nostra galassia, quindi astronomicamente vicine a noi, potrebbero essere decine di milioni. Se si considerano i 100 miliardi di galassie dell’Universo intero si potrebbe raggiungere la cifra fantastica di miliardi di miliardi. Insomma c’è pieno di pianeti abitabili intorno a noi ed è molto probabile che ci sia abbondanza di forme di vita nell’universo. Non c’è alcun motivo di credere che acqua e materia organica siano componenti ultra rari.
Fra qualche tempo saremo in grado di analizzare la composizione dell’atmosfera dei nuovi pianeti che orbitano nelle fasce abitabili per cercare eventuali composti organici, chiari indizi della presenza di forme di vita simili a quelle che ci sono familiari.
Non mi interessa qui discutere il problema delle distanze e neanche la tecnologia con cui potremo stabilire una comunicazione o un contatto. Sarebbe sciocco argomentare oggi intorno a questioni che, ne sono sicuro, faranno sorridere gli scienziati del futuro.
Vorrei invece sottolineare la necessità di prepararsi a quello che sarà sicuramente un grosso choc culturale. Un’umanità che fa fatica a convivere con se stessa, sarà in grado di superare la crisi di valori legata alla scoperta di altre forme di vita? Che rapporti instaureremo fra noi, per prepararci a queste prime forme di contatto con «gli altri»? Noi che nella colonizzazione della terra non siamo stati capaci di praticare altro che depredazione e spoliazione delle popolazioni con cui siamo venuti in contatto, accetteremo di essere «i primitivi» al cospetto di civiltà che si sono sviluppate qualche milione di anni prima di noi? E viceversa, quali relazioni saremo in grado di instaurare con forme di vita, magari simili alle nostre, ma che ci potranno apparire a un livello di sviluppo primordiale? È pensabile che si cominci a ragionare dei problemi etici connessi a questo passaggio? Noi che non siamo in grado di gestire l’integrazione di alcuni milioni di rifugiati o di emigranti che sfuggono la guerra o precarie condizioni di vita, con quali strumenti culturali arriveremo a questo appuntamento che ci chiama a un salto di civiltà?
I nostri pronipoti vedranno un mondo che noi, oggi, possiamo solo immaginare. Riusciremo ad attrezzarci nel giro di qualche generazione a questo cambio di paradigma sul piano antropologico?
Obiettivo Alfa: un altro Sole un’altra Terra
Christophe Galfard
Sapete cos’è un pianeta? Pensiamo tutti di saperlo, ma sapreste darne una definizione, ad esempio parlandone a un bambino? Stranamente non è poi così semplice. Prima del 2006 — dunque dieci anni fa, non un secolo fa — non esisteva neppure una definizione ufficiale. Solo la parola. Pianeta. Parola che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri antenati greci. Per loro questa parola aveva un significato particolare, legato a una strana osservazione, che possiamo fare ancora oggi.
Immaginate di trovarvi all’aperto, in una notte d’estate. Volgete tranquillamente il vostro sguardo verso il cielo e sognate le stelle. Vi proiettate per qualche istante nell’immensità del cosmo, un’immensità che ci invade, ma che, tutto sommato, ci fa del bene. Talmente bene che ritornate il giorno dopo, e quello dopo ancora, e tutti i giorni seguenti, alla stessa ora, per poter continuare il vostro sogno. Da fini osservatori, vi rendete rapidamente conto che alcuni dei punti che luccicano nella notte al di sopra delle vostre teste non si muovono come tutti gli altri. Quasi tutte le stelle si spostano tranquillamente da est a ovest, come fossero attaccate a una sfera trasparente che ruota intorno alla Terra.
In realtà non si muovono affatto, certo. È il movimento della Terra che, girando su se stessa, ci dà questa impressione. Ma non tutte obbediscono a questo movimento collettivo. Alcuni di quei punti luminosi non sembrano affatto attaccati a quella sfera. Alcuni addirittura tornano indietro nel loro cammino e disegnano un anello nel cielo prima di riprendere il loro corso. Questi strani corpi celesti venivano chiamati dai greci stelle viaggianti, o vagabonde. In greco vagabondo si dice plànetes , che nella nostra lingua diventa «pianeta».
Questi punti luminosi che non ruotano come gli altri sono Giove, Saturno, Marte e Venere (quelli che possono essere visti a occhio nudo) e Nettuno, Urano e Mercurio. Non sono stelle. Non brillano di luce propria. Se li vediamo nel cielo è perché riflettono la luce del Sole, il quale sì, è una stella. C’è stato poi bisogno di un certo periodo di tempo per realizzare che la Terra sulla quale noi viviamo è anch’essa un pianeta. E abbiamo dovuto attendere il 2006 — appunto — perché l’Unione Astronomica Internazionale si mettesse d’accordo su una definizione fisica del significato di questo termine.
Dal 2006, dunque, devono essere soddisfatte tre condizioni per far sì che un corpo celeste possa ambire al titolo di pianeta. Eccole. La prima è che il candidato in questione deve girare attorno al Sole e non attorno a qualcos’altro. La Luna, ad esempio, gira attorno alla Terra. Quindi non è un pianeta. È una luna. La seconda condizione per parlare di pianeta è che deve essere tondo. Gli asteroidi, quelle rocce che galleggiano nello spazio vuoto, con la loro forma di patata, non sono pianeti. Sono asteroidi. E che cosa deve succedere perché un corpo celeste sia tondo? È necessario che abbia una massa sufficiente. È la gravità, se sufficientemente forte, con la sua capacità di attirare ogni cosa verso il centro, che trasforma tutto in una palla. La terza condizione per essere un pianeta è che il candidato, rotondo e che gira attorno al Sole, deve aver liberato la sua orbita da tutti i residui che potrebbero essere rimasti. Polveri, rocce, eccetera devono essere scomparsi. Non è così per Plutone, ad esempio, che è tondo, gira attorno al Sole, ma non ha ripulito la sua orbita. Per questo motivo non è più un pianeta. Si dice che è un pianeta nano, o uno pseudopianeta. C’è chi ha trovato la cosa triste, ma se Plutone è stato declassato è perché non è il solo. Oggi conosciamo cinque pianeti nani, ufficialmente riconosciuti come tali. Si chiamano Eris, Ceres, Plutone, Haumea e Makemake. Probabilmente ce ne sono decine d’altri che ancora devono essere scoperti. Alla fine, solo otto astri a noi noti obbediscono ai tre criteri necessari per essere chiamati pianeti. Sono Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Alla fine, dunque, non sono molti. Ma se facciamo a meno del primo criterio, se non esigiamo più che l’astro in questione ruoti attorno al Sole, allora ci attende una sorpresa.
Si entra nella categoria degli esopianeti. Un esopianeta è come un pianeta, ma non gira attorno al Sole. La sua (o le sue, se ce n’è più d’una) stella è diversa dalla nostra.
Altri mondi
Da molto tempo — e intendo secoli — i nostri antenati si sono posti la seguente domanda: esiste un’altra (o molte altre) Terra da qualche parte nello spazio? È possibile che altri mondi orbitino intorno a stelle diverse dal Sole. Naturalmente i nostri antenati non usavano questi termini, ma tra loro c’era chi era già convinto che sì, là in alto esistevano altri mondi, da qualche parte nell’immensità del cosmo. Alcuni di questi visionari coraggiosi ricevettero come ricompensa il privilegio di essere arsi vivi. Eppure avevano ragione.
Oggi ne abbiamo le prove. Sono stati due astronomi svizzeri — Michel Mayor e Didier Queiroz — ad avvistare un esopianeta per la prima volta nella storia dell’umanità. L’hanno chiamato 51 Pegasi b. Era il 1994. Ventidue anni fa. Noi siamo quindi la prima generazione umana a poter affermare con tanto di prove che sì, esistono altri mondi. Oggi, mentre sto scrivendo queste righe, sono noti 3.272 esopianeti. E ce ne sono altri 4.696 in attesa di conferma, il che significa che per questi sono necessarie osservazioni aggiuntive prima di poter affermare la cosa con certezza. Ma questa cifra non dà un’idea accurata del numero di esopianeti esistenti, dal momento che naturalmente non li abbiamo ancora scoperti tutti. La tecnologia impiegata finora per osservare gli esopianeti non ha indagato che un’infima porzione del cielo. Ci sono stelle che non hanno esopianeti nelle loro orbite, ma ce ne sono altre che ne hanno molti. Prendendo in considerazione ogni cosa, contando quelle che ne hanno molti e quelle che non ne hanno affatto, gli scienziati oggi stimano che nella nostra galassia dovrebbero esserci, in media, un po’ più di due pianeti per stella. Questo porterebbe a supporre la presenza di circa 600 miliardi di esopianeti. Solo nella nostra galassia. E di galassie ce ne sono miliardi.
Carl Sagan, il celebre astronomo, ha scritto: «Se siamo soli nell’universo, che posto disordinato deve essere!».
Ma concentriamoci solo sugli esopianeti che conosciamo già e poniamoci un’altra domanda: potremmo mai raggiungere uno di questi mondi un giorno, o inviare un satellite per poterlo osservare da vicino e, magari, scoprire se ospita la vita? Finora nessuno è stato abbastanza pazzo da pensare di poter spedire un oggetto qualsiasi verso un’altra stella. Le distanze, davvero fenomenali, sembrano invalicabili. Ma tutto questo potrebbe essere sul punto di cambiare.
Il primo viaggio interstellare
Nello spazio ci sono stelle ovunque. Deve per forza essercene una che si trovi più vicina al Sole rispetto alle altre. Si chiama Proxima Centauri. Proxima Centauri è una stella minuscola, di un tipo che gli scienziati chiamano nana rossa. Le nane rosse sono molto meno calde del Sole, ma vivono molto, molto più a lungo. Il nostro Sole è una stella solitaria; Proxima Centauri invece fa parte di un piccolo gruppo di tre stelle, chiamato Alfa Centauri. Gli altri due membri del gruppo sono ben più brillanti e ben più vicine tra loro rispetto a Proxima. Si possono vedere bene di notte dalla Terra. Formano un punto, il terzo più brillante del cielo, osservabile però solo dall’emisfero australe.
Attorno alla più piccola di queste due stelle sono stati osservati due esopianeti. Non sono così diversi per dimensioni rispetto alla Terra, ma le loro orbite li rendono piuttosto inospitali: sono troppo vicini alla loro stella e hanno dunque temperature davvero troppo elevate perché si possa sperare di trovarci la vita, almeno così come la conosciamo qui sulla Terra. Ma il fatto stesso che ne abbiamo trovati due, apre l’eccitante prospettiva di trovarne altri, che potrebbero magari avere delle temperature di superficie più clementi.
Se fosse così, non si potrebbe trovare un luogo migliore per iniziare le nostre ricerche sulla vita extrasolare.
Ma è un luogo lontano.
Molto lontano.
Con le attuali tecnologie, con le velocità che al giorno d’oggi possiamo imprimere ai nostri satelliti, dovremmo prevedere un viaggio di circa 30 mila anni.
Ed è qui che Stephen Hawking e Yuri Milner entrano in gioco. Il 12 aprile scorso, in occasione del cinquantacinquesimo anniversario del primo volo spaziale di Yuri Gagarin, Yuri Milner (che si chiama così in omaggio al primo Yuri) ha annunciato il suo progetto — denominato Breakthrough Starshot — di inviare un satellite proprio lì, e con un viaggio di soli vent’anni. Ora la cosa diventa molto più interessante. L’idea, naturalmente, non è quella di usare un normale satellite, bensì un satellite che pesa... meno di un grammo. Un nanosatellite.
È chiaro che la tecnologia per farlo ancora non esiste. Ma non dobbiamo inventare proprio tutto. Ad esempio, esistono già delle macchine fotografiche che pesano quasi nulla, come quelle che si trovano nei nostri telefoni cellulari. Si tratterebbe solo di migliorarle. Per contro, ci sono altri problemi completamente inediti. Eccone uno: come fare a fabbricare un motore a razzo che pesi così poco? La risposta tecnologica che è stata proposta è sconcertante: non utilizziamo alcun motore. L’idea di Milner e Hawking per raggiungere Alfa Centauri è quella di imprimere la spinta al nanosatellite direttamente dalla Terra utilizzando un laser superpotente.
Il nanosatellite, con la sua batteria e la sua macchina fotografica, verrebbe montato su una specie di vela di 4 metri per 4, che verrebbe spinta da un laser, costruito su una montagna dell’emisfero australe, come se ci soffiasse dentro, fino a che l’apparato non raggiunga una velocità prossima ai 160 milioni di chilometri orari. È terribilmente veloce. C’è da sperare di non trovare delle rocce lungo il cammino. D’altra parte, fare la cartografia di tutti i potenziali pericoli del tragitto fa parte dello scopo della missione. E accade che — che colpo di fortuna! — per raggiungere Alfa Centauri il nostro minuscolo satellite non dovrà neppure attraversare il Sistema solare, bensì uscirne, per rendere le cose semplici, in verticale. Attorno al Sole non c’è altro che pianeti che girano in tondo e innumerevoli zone di polvere e rocce. Ma tutti questi oggetti, potenzialmente catastrofici per una simile missione, sono più o meno distribuiti come su un piatto, all’interno di una specie di disco centrato sul Sole; e il sistema di stelle di Alfa Centauri non si trova su questo piano. Ne sta al di sotto. Il nanosatellite, quindi, potrà (e dovrà) abbandonare subito la zona più pericolosa.
Una volta fuori, non c’è che il vuoto interstellare e ci sono ben poche probabilità che incontri delle polveri più grosse dello spessore di un capello. E comunque, per ovviare anche a questa eventualità, la squadra di ingegneri incaricata di portare a compimento il progetto dovrà trovare delle soluzioni che, visto il peso massimo dell’apparato, non risulteranno affatto semplici. A 160 milioni di chilometri all’ora una collisione, per quanto piccola, non perdona. Immaginando che la missione veda la luce e che tecnicamente riesca a svilupparsi, sarebbe la prima volta nella storia dell’umanità che un oggetto umano raggiunge un’altra stella. Si sarebbe così aperto il cammino dei viaggi interstellari, anche se si tratterebbe — è chiaro — di un viaggio di sola andata. Spedire degli esseri umani laggiù è tutto un altro paio di maniche.
Ma se quel nanosatellite trovasse, per caso, un pianeta abitabile, allora, secondo me, le tecnologie per spedire anche degli uomini e delle donne non tarderebbero a fiorire.
(traduzione di Michele Luzzatto)