Dilata i confini della nostra comprensione proiettandoci nell'ascolto più profondo
Aldo Grasso
"Corriere della Sera - La Lettura", 28 ottobre 2012
L'unica forma di silenzio che ci resta è infilarci le cuffie dell'iPod. Ma non è silenzio, è isolamento, una sottile forma di autismo sociale. Prima o poi, però, bisogna fare i conti con il silenzio; finora ci ha rubato troppo tempo il rumore. Ricordo che una decina di anni fa il «New York Times» aveva sigillato in un disco di nichel i suoni più rappresentativi del ventesimo secolo in modo tale che, nel 3000, i nostri discendenti potessero riascoltare la colonna sonora del chiassoso Novecento.
La «capsula del tempo», però, riservava una sorpresa: al posto di Elvis Presley, dei Beatles, dei Rolling Stones, di Bob Dylan, di Bruce Springsteen c'erano solo i rumori di un tosaerba, di un elicottero, di un motore a scoppio, di un ascensore che si ferma al piano, di un aereo che decolla, di uno sciacquone, di un clacson e altri simili. Rumori della quotidianità, rumori spesso fastidiosi, esasperanti, intollerabili. Come mai? Le case discografiche non avevano voluto concedere il copyright delle canzoni che avevano segnato la cultura musicale del secolo. Così l'astuzia della storia si era presa una rivincita decretando l'esecrato rumore come vero timbro sonoro dei nostri anni: il suono del lavoro, della vita che pulsa, della tecnica ma anche dell'insensibilità, della sparizione del silenzio.
Quando assisto a certi talk show mi viene da invocare il ripristino dei «silentiares». Nelle corti imperiali bizantine del IV secolo erano guardie che tutelavano il silenzio nella sala colloqui: la parola era sottoposta a rigido controllo, guai a sgarrare! Già, il silenzio riusciamo a definirlo solo attraverso il suo opposto.
Ne Il silenzio del corpo, Guido Ceronetti scrive che «chi tollera i rumori è già un cadavere». Per questo sono rimasto colpito da una notizia: nel Sussex un parroco ha registrato il silenzio della chiesa e ne ha prodotto «la sua pace» su cd. Trenta minuti di silenzio, registrato all'interno di una chiesa anglicana della campagna inglese, da riascoltare a casa per rivivere l'atmosfera sacra e accogliente di un edificio di 900 anni fa. Il cd si intitola The sound of silence (Il rumore del silenzio) come la vecchia canzone di Simon & Garfunkel (ma, prima, ci si doveva accontentare de La voce del silenzio cantata da Mina: «Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai, vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto…»).
Non avendo orecchio musicale, ho letto senza troppo costrutto le teorie sul silenzio di John Cage; una cosa però mi è rimasta: il silenzio non è un'assenza, non è un vuoto, il silenzio ha una sua grammatica, una sua pienezza. Il rapporto fra rumore e silenzio ricorda molto quello fra memoria e oblio. Che è uno dei nessi più inestricabili e complessi che la storia della cultura occidentale abbia tramandato; nei racconti, nelle manifestazioni, nelle polverose teche tutto sembra parlare a favore della memoria, la quale, a differenza dell'oblio, gode di una trattatistica esuberante. Una sorta di mitologia cupa avvolge invece le pianure dell'oblio e da sempre assistiamo alla lotta sorda che l'oblio combatte per riscattare la sua fama compromessa. E infatti Baltasar Gracián diffida della memoria nemica del silenzio, delle tenebre, del segreto.
Non avendo neppure particolare attitudine filosofica, non oso affrontare i «sovrumani silenzi» e la «profondissima quïete» di cui parla Leopardi, raccogliendo piuttosto il sacrosanto invito di Wittgenstein: «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Il silenzio è anche una forma di rispetto nei confronti della conoscenza cui invano aspiriamo, è accettazione della propria limitatezza.
Mi basterebbe capire perché non siamo più capaci, quando capita, di osservare un minuto di silenzio negli stadi o perché nel corso di un funerale ci abbandoniamo all'applauso. Il silenzio non ci appartiene più, non lo riconosciamo. Per esprimere quella cupa, muta e sorda ebetudine che tramortisce quando le grandi disgrazie premono, ci abbandoniamo a una sinistra euforia: sfogarci, applaudire.
Nel libro Per una storia del silenzio (edito da Mursia) Sergio Cingolani avverte che «più della metà della popolazione mondiale vive in ambienti con un livello medio di rumorosità superiore a 60 decibel, quindi assai lontana dalla possibilità di poter godere degli effetti del silenzio». Non conosciamo più cosa sia il silenzio, nemmeno nella quiete della campagna o della montagna: c'è sempre qualche fanatico del motocross che ci vuol far sapere che esiste.
Il capitolo più interessante del libro mi è parso quello dedicato al silenzio nelle regole monastiche. In quelle di Benedetto (480-547) sta scritto: «Facciamo quello che dice il Profeta: “Ho detto: custodirò le mie vie per non peccare con la mia lingua; ho posto una custodia alla mia bocca, ho tenuto il silenzio, mi sono umiliato e ho taciuto…». Dalla sua cella il monaco non può né vedere né sentire il suo vicino, l'architettura monastica è fatta per proteggere il silenzio, la meditazione, la taciturnitas. Il silenzio è una grande cerimonia, una liturgia. Dio giunge nell'anima che fa regnare il silenzio dentro di sé, ma rende muto chi si perde in chiacchiere.
La cultura laica pare poco interessata al silenzio. Per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (maggio 2012) Benedetto XVI ha invece inviato un messaggio dedicato proprio al silenzio: «Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero». Il Papa non ha proposto il silenzio come alternativa all'impegno nella comunicazione, non ha chiesto di spegnere la «musica passiva» (la musica non richiesta che ci assilla nei negozi, nei locali pubblici, negli ascensori, nelle spiagge…), non ha improvvisato una di quelle lezioni per dummies o per manager in cui ci viene spiegato, da una pubblicistica improvvisata, che «in una società in cui tutti parlano, tutti tentano di esprimersi sovrapponendo la propria voce a quella degli altri e in cui gli stimoli dei soggetti emittenti si moltiplicano spesso senza raggiungere i destinatari del messaggio il rischio dell'incomunicabilità cresce a dismisura». No, ha voluto ricordare che il silenzio parla, anche nelle moderne forme di comunicazione. Il silenzio è una scelta e a volte può essere l'espressione più eloquente della nostra vicinanza, della nostra solidarietà, della nostra attenzione verso un'altra persona.
Sul mistero del silenzio Gianfranco Ravasi ha scritto: «Il silenzio per sua natura è una realtà radicalmente ambigua. Da una parte esiste il cosiddetto "silenzio nero", che è l'assenza dei suoni, delle voci. Nella Bibbia si legge: "Quando Dio maledice un popolo, fa cessare il canto dello sposo e della sposa". Cassiodoro, nel VI secolo, scrisse nelle Istituzioni una frase folgorante e straordinaria: "Se voi continuerete a commettere ingiustizia, Dio vi lascerà senza la musica". Dall'altra parte invece esiste il cosiddetto "silenzio bianco". Nelle religioni è fondamentale il nome di Dio: da dire, da invocare. Israele, nell'Antico Testamento, introduce l'idea che vada taciuto. Il profeta Elia va sul monte Sinai per ritrovare le radici della sua vocazione e vuole scoprire Dio con l'imperio, abituale, della teofania: i tuoni, il terremoto che sommuove la terra, le folgori che scorticano gli alberi... Invece lo scopre nelle frase: "E alla fine ci fu il mormorio di un vento leggero". In ebraico abbiamo soltanto tre parole: "voce, silenzio, sottile". Dio è una voce di silenzio sottile. Da lì in avanti comincia la grande via del "silenzio bianco", che non è assolutamente il terrore di star soli. L'uomo di oggi non è più capace di star solo perché ha sempre davanti il vuoto».
Sarebbe interessante affrontare un'estetica del silenzio. In Forme del parlare, il sociologo Erving Goffman capovolge il senso comune e sostiene che «il silenzio è la norma e parlare è qualcosa che esige una giustificazione». Come molti della mia generazione, sono cresciuto frequentando i cineforum, guardando i film di Ingmar Bergman, in particolare la cosiddetta «Trilogia del silenzio di Dio» (Come in uno specchio, 1961, Luci d'inverno, 1961, e Il silenzio, 1963), dominata dal tema dell'incomunicabilità. Il silenzio di Dio si riflette nel silenzio degli uomini e delle donne, lascia spazio alla violenza fisica e verbale. Ne Il silenzio Anna ed Ester sono due sorelle che stanno tornando dalle vacanze assieme a Johan, il figlio adolescente di Anna. La loro meta è la Svezia ma devono attraversare un Paese sconosciuto sull'orlo della guerra. Il rapporto conflittuale tra le due donne esplode e dopo l'ennesimo litigio Ester, gravemente ammalata di tubercolosi, viene abbandonata dalla sorella al suo destino. Ma la vera tragedia è che Dio tace perché è l'uomo ad aver stabilito le regole di questo dialogo, ad aver fissato la misura delle sue richieste. Parliamo, cerchiamo affannosamente il rumore perché copra il silenzio che più ci spaventa.
Il silenzio ci appare oggi come un vuoto angoscioso, così angoscioso da preferirgli il rumore, il chiacchiericcio, persino l'acufene, la vera colonna sonora della modernità. Eppure, la nostra epigrafe sarà solo quella dettata da Ceronetti: «La vita rimescola dati e dadi; l'ultima parola, su tutto, la dirà il silenzio».

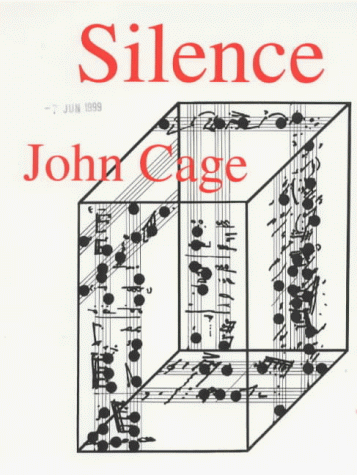
Nessun commento:
Posta un commento